Categoria: software
-
Uso delle API di OpenAI per WordPress
Scopri come le API di OpenAI trasformano il tuo WordPress!
-
Coding per docenti
Tutti possono programmare (cit. Ratatouille) 0.I programmatori sono professionalmente autoreferenziali.Nel senso che scrivono per essere letti da una casta ristretta: i computer, loro stessi e i pochi altri in grado di apprezzare le loro finezze. Se qualcun altro non capisce il loro codice sorgente, è un problema suo e non vale la pena di averci…
-
LLM in Libre Office
Mini-tutorial Obiettivi L’idea è di provare ad usare i grandi modelli linguistici in una rete locale, senza inviare dati a servizi remoti e usando solo software opensource. Concetti I modelli sono file. Questi file vanno “eseguiti” cioè resi interrogabili o direttamente, o tramite API. Di questo si occupano programmi come Ollama, applicazione opensource mantenuta da…
-
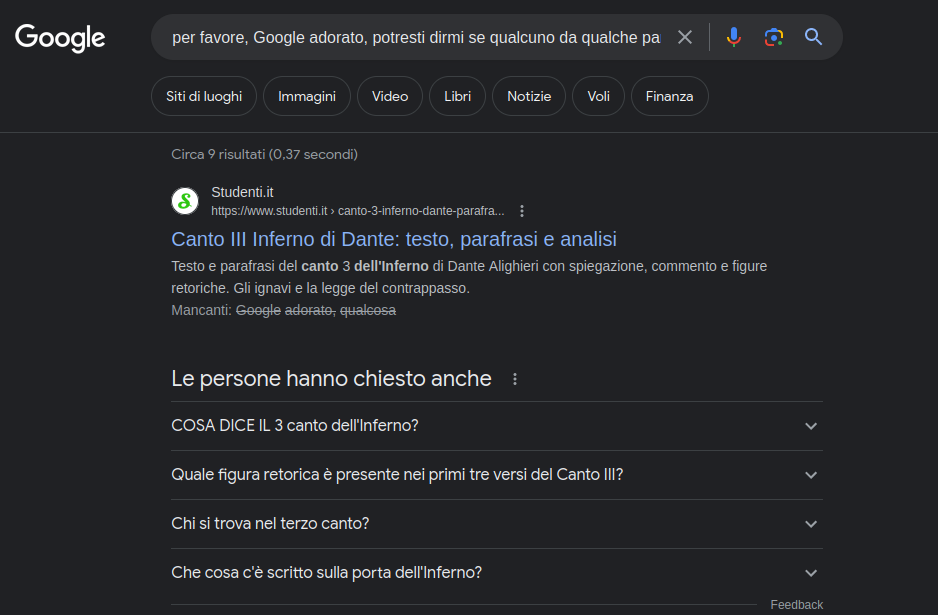
Prompt: chi parla?
Didattica della finzione artificiale Questo testo è stato pubblicato per la prima volta come una serie di articoli sul sito Gessetti Colorati, nella rubrica dedicata al dibattito sull’intelligenza artificiale (https://www.gessetticolorati.it/dibattito/intelligenza-artificiale/) 0. Introduzione: perché i docenti studiano l’intelligenza artificiale? Come in ogni occasione in cui qualche strumento viene inventato e proposto sul mercato delle professioni della…
-
Neo-luddismo
Mi è stato fatto notare, anche implicitamente, che ho una posizione contraddittoria sull’intelligenza artificiale, in particolare sul suo uso a scuola.“Ma come, proprio tu sei contrario? Tu che hai iniziato a fare coding ante litteram nei primi anni ’90 col Logo e il BASIC?Che hai scritto software educativi persino per i poveri bambini della scuola…
-
WonderPark, ovvero come avrebbe potuto essere il software per bambini
Anno 1996. La startup Lynx, uno spin-off non ufficiale del Laboratorio di Tecnologie Audivisive di Roma Tre, progetta realizza e produce in proprio WonderPark, un software per bambini piccoli, quelli che oggi non devono toccare i tablet perché poi non imparano a scrivere in corsivo (ma si sa, quelli nati nel ’90 era diversi). Un…
-
Strumenti digitali usati analogicamente
Mi sono reso conto improvvisamente (eh sì) che la mia maniera di pensare la “didattica digitale” è spesso lontana da quella di molti che in teoria dovrebbero essere dalla mia stessa parte, la parte di quelli che studiano, sperimentano e propongono agli altri attraverso corsi, libri, seminari e sogni vari. Ci troviamo vicini, ci salutiamo…
-

Basta coi dati, ancora più dati
Dati come algoritmi: ne parlano tutti, a qualsiasi proposito, a volte anche confondendoli. E si capisce, perché gli algoritmi senza dati girano a vuoto. Si legge e si ascolta sempre più spesso “I dati ci dicono che”, “Andiamo a vedere i dati”, “Ci vogliono nascondere i veri dati”. Ma a forza di citarli come risposta…
-

La fine della formazione
La formazione professionale ha senso se esiste una professione d’arrivo, cioè se esiste il contesto in cui una certa competenza può essere esercitata, riconosciuta, richiesta, pagata. Quando il contesto scompare, scompare la professione, e scompare anche la formazione. E’ questo lo scenario che ci aspetta grazie alla creazione di modelli di Machine Learning addestrati a…
-
Pensiero computazionale sì o no? Boh, dipende dal linguaggio.
Una delle motivazioni dietro la spinta all’introduzione della programmazione dei computer in giovane età (=coding) è quella per cui questa pratica insegna il pensiero computazionale, che è un modo di affrontare i problemi in maniera scientifica. Anche se Jeannette Wing si è affannata a dire che non si tratta di insegnare ai bambini a pensare…